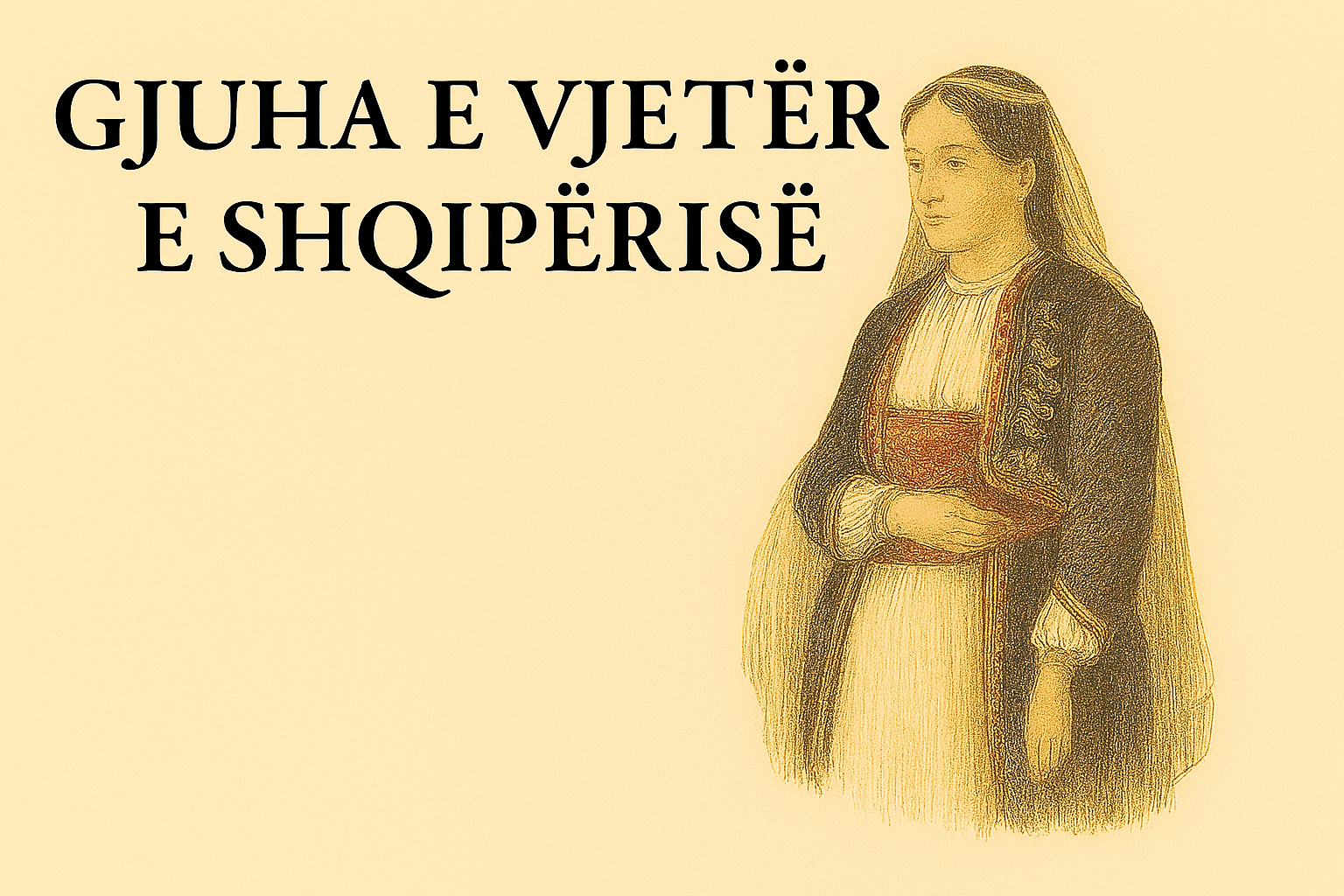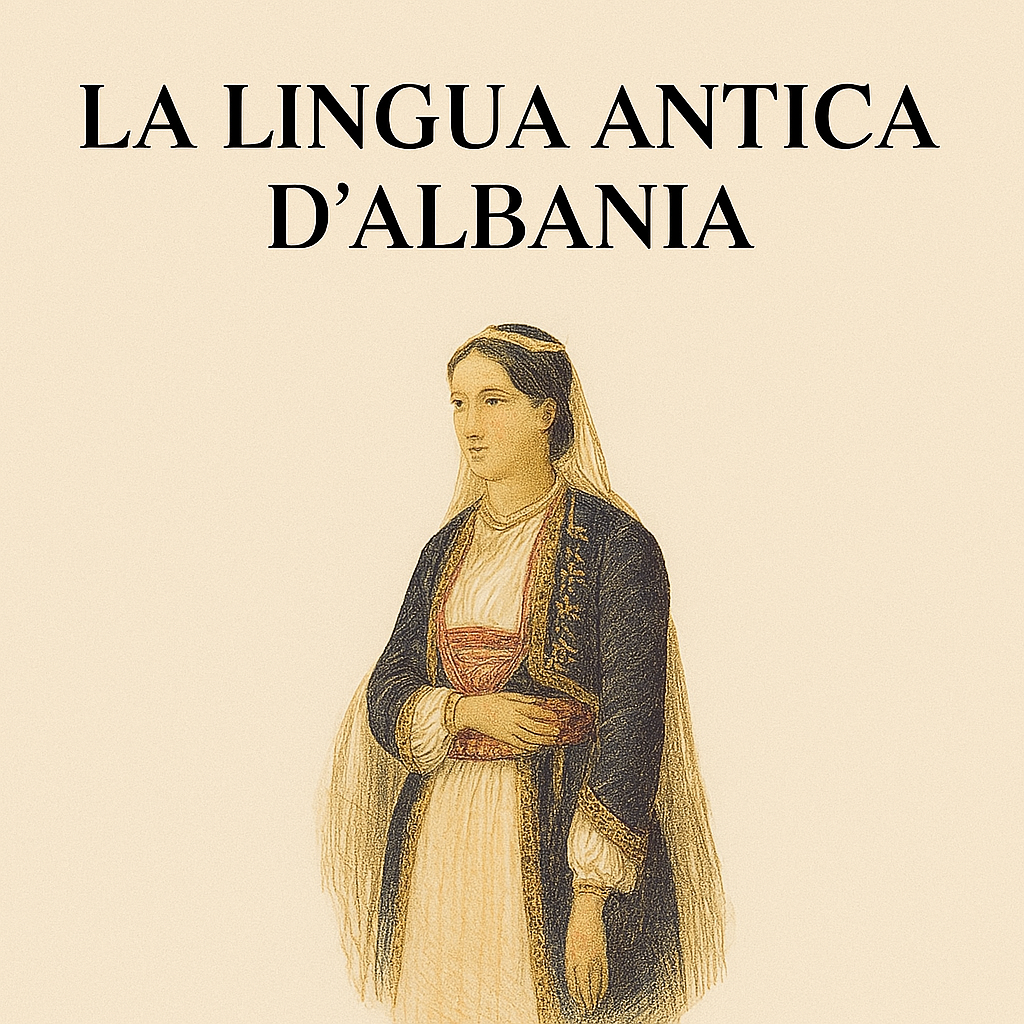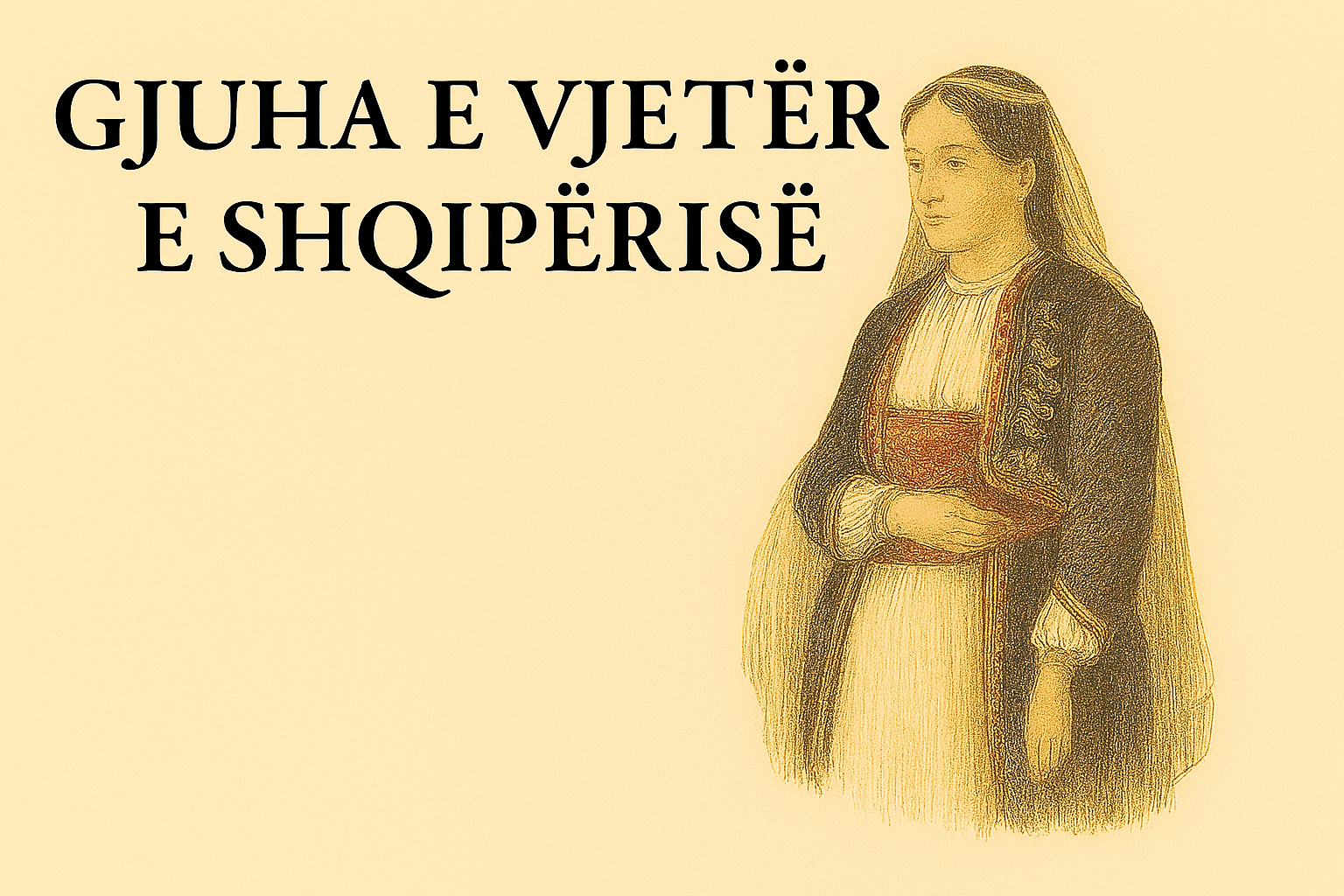PARLARE LA LINGUA DELLE RADICI
NEL CUORE DELLA CALABRIA LA MEMORIA ARBËRESHË
Di Francesca Gallello Gabriel Italo Nel Gòmez
Vivere in Calabria significa abitare una terra di passaggi, di radici profonde e di voci che non smettono di parlare. Come scrittrice e poetessa, ho sempre sentito il dialetto come la lingua delle mie radici—una lingua che non solo racconta, ma custodisce. Scrivere in dialetto per me è un gesto d’amore, un modo per restare vicina alle voci che mi hanno cresciuta, ai gesti che non voglio dimenticare.
Negli ultimi anni, ho avuto il privilegio di collaborare con autori albanesi e kosovari, di presentare libri in Albania, di ascoltare storie che sembrano specchiarsi nelle nostre. Da questo legame affettivo e culturale è nata la volontà di dedicare un articolo al dialetto arbëreshë, alla lingua albanese antica che ancora oggi vive in Calabria, nei borghi che resistono, nelle famiglie che tramandano, nei canti che non si lasciano spegnere.
È un omaggio alla memoria, alla contaminazione, alla bellezza di appartenere a più mondi senza perdere sé stessi.
Nel cuore della Calabria, tra borghi arroccati e vallate silenziose, risuona ancora una lingua che non è né italiana né albanese, ma qualcosa di più antico e più intimo: l’arbëreshë. È il dialetto delle comunità albanesi che, secoli fa, attraversarono l’Adriatico per sfuggire all’invasione ottomana. Non vennero come conquistatori, ma come profughi. Eppure, nel dolore dell’esilio, portarono con sé una lingua, una fede, una cucina, un modo di vestire e di cantare che ancora oggi resiste. La migrazione arbëreshë verso l’Italia iniziò tra il XIV e il XVIII secolo, con ondate più consistenti dopo la morte dell’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Scanderbeg nel 1468. Fuggendo dalla conquista turca, le famiglie albanesi trovarono rifugio nel Regno di Napoli, che concesse loro terre spopolate in cambio di fedeltà militare. In Calabria si stabilirono in zone collinari e interne, fondando borghi che ancora oggi portano nomi e suoni albanesi: Acquaformosa, Andali, Caraffa di Catanzaro, Carfizzi, Castroregio, Cavallerizzo, Cervicati, Cerzeto, Civita, Ejanina, Falconara Albanese, Farneta, Firmo, Frascineto, Gizzeria, Lungro, Macchia Albanese, Marcedusa, Marri, Mongrassano, Pallagorio, Plataci, San Basile, San Benedetto Ullano, Santa Caterina Albanese, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Giacomo di Cerzeto, San Martino di Finita, San Nicola dell'Alto, Santa Sofia d'Epiro, Spezzano Albanese, Vaccarizzo Albanese, Vena di Maida, Zangarona. In questi luoghi, la lingua arbëreshë non è mai stata solo un mezzo di comunicazione, ma una casa portatile, costruita con suoni, memorie e gesti. È una variante arcaica del tosco, parlato nel sud dell’Albania, mescolato a vocaboli italiani assimilati nei secoli. È una lingua che ha resistito all’omologazione, tramandata oralmente, celebrata nei canti polifonici, nelle messe in rito bizantino, nei racconti delle nonne. Oggi, solo il 45% dei vocaboli è di origine albanese: il resto è frutto di contaminazione, adattamento, sopravvivenza. Scrivere in arbëreshë è un atto di memoria. Ogni parola è un ponte tra l’Albania e l’Italia accogliente. Ogni frase è una dichiarazione d’identità. Ma la lingua non è l’unico elemento conservato. Gli arbëreshë hanno mantenuto il rito cattolico bizantino, con messe cantate e gesti liturgici orientali, gli abiti tradizionali ricamati d’oro, indossati durante le Vallje, danze rituali che celebrano la primavera e la libertà, la cucina, con piatti che mescolano ingredienti locali e ricette balcaniche, e la musica, tramandata oralmente, spesso in forma corale. Pasolini definì gli arbëreshë «un miracolo antropologico». E aveva ragione: sono riusciti a integrarsi senza perdere sé stessi. In un’epoca di globalizzazione, il dialetto arbëreshë è un atto di resistenza culturale. È una lingua minoritaria riconosciuta dalla legge italiana, ma ancora fragile, a rischio di estinzione se non tramandata. Le scuole, i festival, le pubblicazioni bilingui, i musei etnografici sono strumenti fondamentali per mantenerla viva. Ogni parola arbëreshë è una radice che non vuole morire. Ogni bambino che la impara è un ramo che fiorisce.
Il dialetto arbëreshë non è solo una lingua: è una casa. È la prova che si può essere esiliati e radicati allo stesso tempo. Che si può appartenere a due terre, due tempi, due cuori. E in Calabria, tra le pietre antiche e le voci che resistono, questa casa continua a parlare. Scrivere questo articolo è stato per me un gesto di riconoscenza. Verso una lingua che resiste, verso una comunità che tramanda, verso una Calabria che non smette di essere ponte. L’arbëreshë non è solo un dialetto: è una voce che ha attraversato il mare, ha trovato rifugio, e ha saputo fiorire. È la prova che le radici non si misurano in confini, ma in parole che continuano a vivere.
A chi parla ancora questa lingua, a chi la insegna, a chi la canta, a chi la scrive: questo è per voi. E a chi la ascolta per la prima volta, con curiosità e rispetto: benvenuti in una casa fatta di memoria.