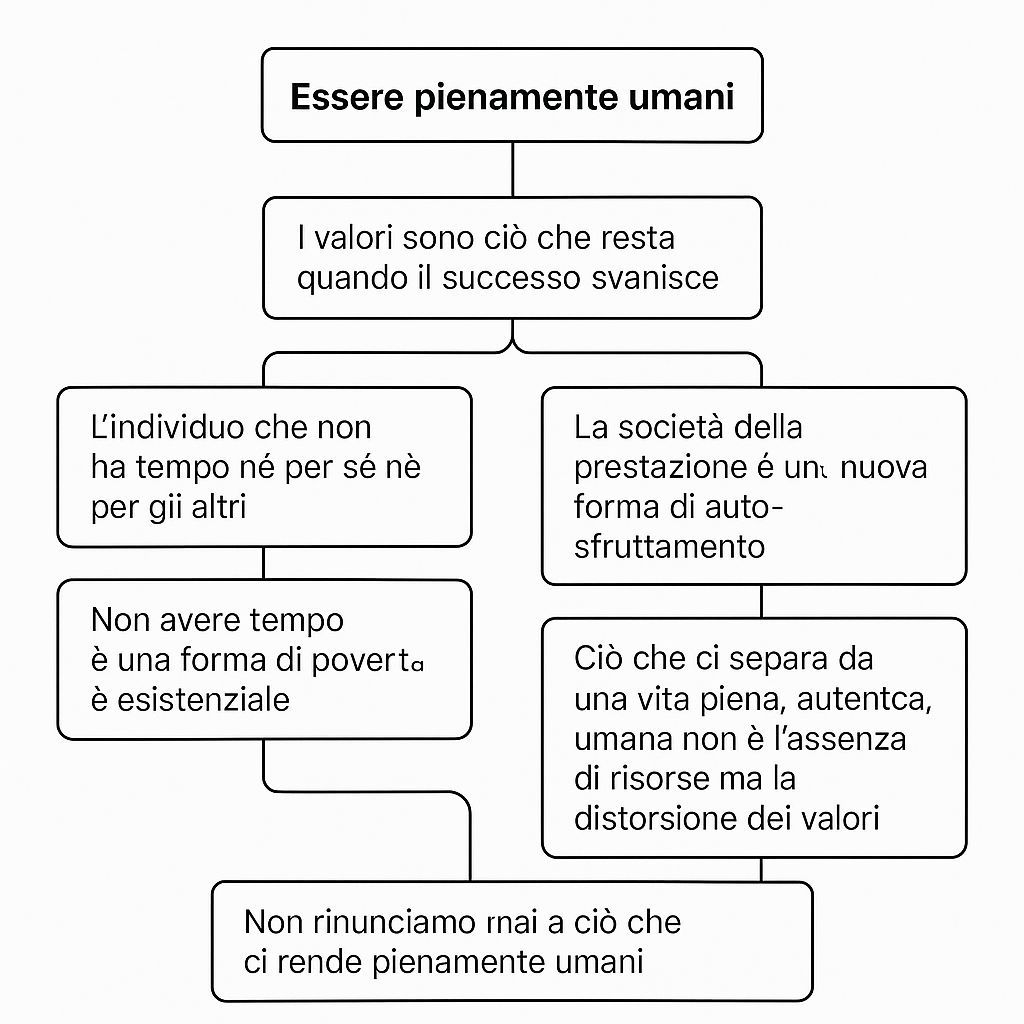ANGELA KOSTA
ANGELA KOSTA - EGOISMO E IPOCRISIA: LE MASCHERE DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
PRIMA PARTE
L’egoismo e l’ipocrisia sono due fonti di veleni silenziosi dell’anima contemporanea, due fratelli gemelli che si travestono con abiti diversi, ma che nel profondo condividono la stessa fame: la fame verso sé stessi. In un’epoca che proclama l’individualismo come libertà e la finzione come diplomazia, queste due presenze si muovono indisturbate, crescono, si moltiplicano, si radicano anche nei terreni più insospettabili: amicizie, famiglie, comunità, ambienti intellettuali, religiosi, artistici.
L’egoismo, contrariamente a ciò che si pensa, non è semplicemente l’amore per sé, ma l'incapacità di vedere l’altro. È una forma di cecità selettiva, una malattia dell’empatia. L’egoista non è soltanto colui che vuole tutto per sé, ma anche colui che ignora deliberatamente il mondo al di fuori del proprio orizzonte d'interesse. È un artista della manipolazione emotiva, perché sa celare il proprio egocentrismo dietro nobili parole: “sto pensando al mio benessere”, “nessuno lo farà per me”, “prima io, poi gli altri”. Eppure l’egoismo non è amore di sé, ma paura. Paura di essere vulnerabili, di dover condividere, di uscire dalla zona di controllo. L’egoista costruisce muri e li chiama confini, erige troni nei deserti e si crede re, ma alla fine non dialoga con nessuno, neanche con se stesso.
L’ipocrisia, invece, è il teatro dell’anima. Non è il mentire, ma l’indossare una verità che non ci appartiene. L’ipocrita non dice il falso, dice il conveniente. Sa usare le parole come specchi deformanti, riflettendo ciò che gli altri vogliono vedere. È l’artigiano della coerenza apparente. L’ipocrisia è così sottile che spesso ne siamo vittime e carnefici allo stesso tempo. La società premia il sorriso finto, la frase giusta nel momento giusto, l'apparenza curata più della sostanza interiore. Chi è trasparente viene spesso percepito come inopportuno. L’ipocrisia non ha più bisogno di nascondersi: oggi è protocollo, strategia, etichetta. L’ipocrita moderno non ha doppia faccia: ne ha molteplici, come maschere che cambia a seconda dell’occasione. Il suo talento è l’adattabilità, ma senza radici; la sua fragilità, l’assenza di verità.
Eppure, la cosa più inquietante è che egoismo e ipocrisia non sono sempre espliciti. Possono indossare l’abito del benefattore, dell’amico fedele, del genitore protettivo, dell’attivista. Possono parlare la lingua della bontà, ma senza mai ascoltare veramente. Possono fingersi altruismo: fare qualcosa per gli altri, ma solo se torna utile. Possono fingersi empatia: dire “ti capisco” per ottenere consenso. Sono, in un certo senso, una spiritualità corrotta: sembrano elevarsi, ma mirano soltanto a sopravvivere nel proprio riflesso.
Il dramma di questa doppia realtà è che spesso le due cose convivono perfettamente: l’egoista ipocrita è la figura più diffusa dei nostri tempi. Non solo vuole tutto per sé, ma pretende anche di essere lodato per la sua falsa generosità. Agisce per sé e recita per gli altri. Non è un mostro, non è nemmeno crudele: è soltanto profondamente vuoto. Ed è proprio questo vuoto che alimenta il bisogno di costruire facciate, di mascherare il proprio desiderio di dominare sotto l'apparenza del sacrificio.
Esiste una cura a tutto ciò? Forse...
Ma non verrà dalla morale, né dalle regole.
Verrà da una rivoluzione silenziosa dell’anima: il coraggio di essere sinceri. Non perfetti, non sempre altruisti, ma autentici. L’antidoto all’egoismo non è l’annullamento di sé, ma la coscienza dell’altro. L’antidoto all’ipocrisia non è la brutalità, ma la trasparenza interiore. Smettere di agire per essere visti, e iniziare ad agire per essere veri. Accettare di deludere, di essere fraintesi, ma rimanere fedeli a ciò che si è.
In fondo, egoismo e ipocrisia non sono altro che due tentativi falliti di fuggire dalla fragilità. E forse, solo accogliendo questa fragilità, possiamo cominciare davvero a vivere.
Accogliere la fragilità non significa glorificare la debolezza, ma riconoscere che siamo creature finite in cerca di senso, non maschere perfette da esibire. In un mondo che ci insegna a competere, a primeggiare, a nascondere ogni crepa, chi sceglie la trasparenza diventa rivoluzionario. Eppure, è solo nel riconoscere le proprie crepe che la luce può entrare, come scriveva Leonard Cohen.
Chi rifiuta l’egoismo non diventa per forza martire, così come chi rinuncia all’ipocrisia non diventa necessariamente emarginato. Sono scelte lente, quotidiane, fatte di gesti silenziosi: ascoltare invece di reagire, donare senza aspettarsi un applauso, rimanere coerenti anche quando nessuno guarda. Non si tratta di raggiungere una purezza ideale, ma di camminare verso un centro più autentico.
In fondo, l’egoismo nasce da una ferita di fiducia: la convinzione che se non pensiamo a noi stessi, nessuno lo farà. L’ipocrisia nasce dalla paura del rifiuto: l’ansia che, se ci mostriamo per ciò che siamo, saremo messi da parte. Ma vivere secondo queste logiche significa accettare una solitudine strutturale, una distanza permanente tra sé e il mondo.
La società non cambierà finché l’egoismo sarà considerato intelligenza e l’ipocrisia diplomazia. Cambierà solo quando verrà valorizzato chi sceglie la verità anche a costo della fatica, del silenzio, dell’incomprensione. Ciò che serve non è solo educazione, ma rieducazione emotiva e spirituale: insegnare fin da piccoli che il valore non sta in ciò che si mostra, ma in ciò che si è.
Questo saggio non offre soluzioni rapide, perché non ne esistono. Ma suggerisce una via possibile: quella dell’autenticità come resistenza. Non è una moda, non è un hashtag, è una scelta lenta e spesso solitaria. Ma è anche l’unica che può costruire legami veri, parole che curano, comunità che accolgono. In un mondo affamato di superbia, la verità sarà il gesto più raro e più prezioso.
Socrate diceva: "Conosci te stesso", una frase tanto semplice quanto destabilizzante. Nell’epoca dell’egoismo lucido e dell’ipocrisia strategica, conoscere davvero sé stessi, implica smascherare il proprio opportunismo, guardare in faccia le proprie paure, ammettere quanto spesso cerchiamo applausi più che verità. Conoscersi vuol dire anche riconoscere i momenti in cui scegliamo il comodo silenzio invece del coraggio della parola.
Platone, suo allievo, avvertiva: "Il prezzo che gli uomini buoni pagano per l’indifferenza alla cosa pubblica è di essere governati da uomini peggiori di loro." L’egoismo moderno si manifesta anche nell’indifferenza: chi si ritira nel proprio piccolo mondo privato, chi finge di non vedere pur di mantenere la propria pace interiore, contribuisce, suo malgrado, all’espansione dell’ipocrisia sociale. Il silenzio dei giusti è spesso più pericoloso del rumore degli ipocriti.
Aristotele ci ricorda che "L’uomo è per natura un animale politico", e dunque non può sottrarsi all’altro senza tradire sé stesso. L’egoismo lo isola, lo separa dalla sua natura dialogica. L’ipocrita invece recita una relazione, finge prossimità ma coltiva distanza. Entrambi, in modi diversi, negano l’essenza dell’umano che è relazione, cura, confronto.
Epitteto suggeriva: "Non sono le cose che ci turbano, ma il giudizio che abbiamo su di esse." L’ipocrita, temendo il giudizio altrui, si nasconde sotto maschere sempre nuove, mentre l’egoista costruisce muri contro tutto ciò che potrebbe metterlo in crisi. Entrambi vivono nella paura: del rifiuto, del confronto, dell’autenticità. Filosofi come lui ci spingono a disinnescare quel giudizio, non a manipolarlo.
Seneca, con il suo stoicismo, ci ha lasciato un avvertimento: "Viviamo come se dovessimo vivere per sempre, mentre ogni giorno è l’ultimo." L’egoismo dimentica la finitezza, l’ipocrisia nega l’urgenza. Chi sceglie la verità, invece, abita il tempo con consapevolezza e rispetto, perché sa che ogni gesto è irripetibile e ogni relazione preziosa. Tutti questi pensatori ci riportano a una conclusione comune: essere autentici è difficile, ma è l’unica strada verso una vita che non sia solo sopravvivenza. Resistere all’egoismo e all’ipocrisia non è eroismo, è semplicemente il compito più alto dell’essere umano. Convinti, possiamo dire che l'egoismo e l'ipocrisia non sono solo difetti morali: sono forme di distorsione dell’identità. Chi vive per sé e finge con gli altri, in realtà è in guerra con la propria coscienza. E la coscienza, per quanto soffocata, trova sempre il modo di farsi sentire, a volte nel silenzio, a volte nell’inquietudine, a volte in quella sottile insoddisfazione che accompagna anche i successi più apparenti.
Siamo abituati a considerare l’egoismo come istinto di sopravvivenza e l’ipocrisia come strategia sociale. Ma entrambe sono fallimenti di maturità interiore. Il vero coraggio oggi è essere autentici in un mondo che premia la maschera. Il vero atto rivoluzionario è dire la verità anche quando non conviene, aiutare anche quando nessuno guarda, rinunciare a ciò che ci fa comodo se danneggia qualcun altro.
Socrate ha scelto la morte piuttosto che tradire la verità. Oggi morire non ci viene chiesto, ma ci viene chiesto ogni giorno di scegliere: vivere come ombre che fingono o come esseri umani che si mettono in gioco, anche rischiando. Perché l’anima si salva non con le menzogne o i successi personali, ma con la limpidezza dello sguardo verso l’altro.
In un tempo in cui tutti corrono per emergere, il vero filosofo, il vero poeta, il vero essere umano si ferma, guarda e ascolta. E sceglie di essere ponte, non barriera. Voce, non eco. Verità, non convenienza. E in questo atto semplice, c’è tutta la dignità dell'essere umano.
L’egoismo e l’ipocrisia, questi due fenomeni profondamente radicati nella società contemporanea, influenzano non solo le dinamiche collettive ma anche la vita interiore degli individui. Questi due atteggiamenti, seppur apparentemente distinti, condividono un comune denominatore: la mancanza di autenticità e la difficoltà a stabilire relazioni sincere e profonde.
L’egoismo, inteso non come sano amor proprio, ma come chiusura narcisistica verso l’altro, è stato spesso analizzato da filosofi come Thomas Hobbes, che nella sua visione pessimistica della natura umana vede l’uomo come fondamentalmente mosso dall’interesse personale. Questo orientamento esasperato verso sé stessi produce una società frammentata, dove la cooperazione è sacrificata sull’altare della competizione sfrenata e dell’accumulo individuale. L’egoismo conduce all’isolamento, all’incapacità di comprendere e accogliere l’altro nella sua diversità, generando così un senso profondo di solitudine e alienazione.
L’ipocrisia, d’altro canto, è descritta magistralmente da autori come Jean-Jacques Rousseau, che la considerava un male sociale, figlio delle pressioni sociali e della necessità di adattarsi a convenzioni spesso ingiuste. L’ipocrita non è semplicemente chi mente, ma chi indossa una maschera per celare le proprie vere intenzioni o sentimenti, spesso per convenienza o paura del giudizio. Questa dissimulazione mina la fiducia reciproca e genera sfiducia, un'amarezza lenta che corrode le relazioni umane più profonde e autentiche.
Gli effetti di egoismo e ipocrisia sugli individui sono molteplici e dolorosi. Innanzitutto, essi alimentano un circolo vizioso di insoddisfazione e infelicità. L’egoista, pur credendo di perseguire la propria felicità, spesso si trova imprigionato in una gabbia di desideri insaziabili e solitudine affettiva. L’ipocrita, invece, vive costantemente nel timore di essere smascherato, in un conflitto interiore che mina la propria integrità psicologica.
Autori come Friedrich Nietzsche hanno sottolineato come la sincerità verso sé stessi sia un atto di coraggio e di forza, capace di liberare l’individuo da queste catene interiori. Solo riconoscendo e accettando la propria vulnerabilità si può sfuggire alla trappola dell’egoismo e dell’ipocrisia, aprendosi a relazioni più autentiche e a una vita più piena.
Sul piano sociale, l’egoismo favorisce la frammentazione, l’individualismo esasperato e la perdita del senso di comunità. L’ipocrisia, alimentando falsità e simulazioni, ostacola il dialogo e la costruzione di un tessuto sociale basato sulla fiducia e sulla cooperazione. Entrambi contribuiscono a una crisi delle istituzioni e delle relazioni sociali, rendendo difficile la costruzione di una società giusta e solidale.
Ecco perché, l'egoismo e l'ipocrisia non sono solo difetti morali, ma sono veri e propri ostacoli al benessere individuale e collettivo. Solo attraverso un percorso di consapevolezza e autenticità, come suggerito da filosofi antichi e moderni, è possibile sperare in una società più umana, capace di valorizzare la relazione, la trasparenza e il rispetto reciproco.
Nella società odierna, una delle forme più subdole di inaridimento umano è l’assenza di gratitudine. Viviamo in un tempo in cui molti danno per scontato l’impegno altrui, l’affetto ricevuto, i sacrifici fatti in silenzio. Esiste una categoria sempre più diffusa di individui che non ringraziano, non riconoscono, non vedono: si comportano come se tutto fosse loro dovuto. Questa mentalità, radicata nell’egoismo e alimentata dall’ipocrisia, è uno specchio dell’impoverimento spirituale del nostro tempo.
Ritornando dal filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, portiamo ciò eglivparlava dell’uomo risentito, colui che, incapace di generare valore da sé, vive nella pretesa e nel rancore. E proprio questa figura si avvicina a chi non conosce la gratitudine: pretende senza mai interrogarsi sul costo umano di ciò che riceve. Vive con la convinzione che ogni gesto di bene gli spetti di diritto. In realtà, è vittima di un narcisismo strutturale, figlio di una cultura che ha confuso l’autostima con l’autosufficienza, il diritto con il privilegio, la libertà con l’egocentrismo.
Anche dietro l’assenza di gratitudine si nasconde una profonda miopia affettiva e morale ma di questo parleremo in seguito…
Da Angela Kosta giornalista, poetessa, saggista, editore, critica letteraria, redattrice, traduttrice, promotrice