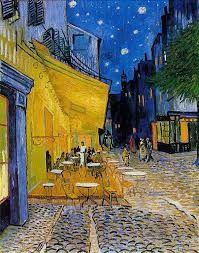RIFLESSIONI SULLA PITTURA MODERNA
Riflessioni sulla Pittura Moderna
di Souad Khalil*
L’arte moderna, come definita su Wikipedia, si riferisce alle opere artistiche emerse approssimativamente dagli anni Sessanta del XIX secolo fino agli anni Settanta. Il termine indica gli stili e le filosofie dell’arte prodotti durante quel periodo. Di solito, il termine si associa all’arte in cui le convenzioni tradizionali sono state abbandonate a favore dell’innovazione. Gli artisti contemporanei hanno sperimentato nuovi modi di vedere, oltre a nuovi concetti riguardo alla natura dei materiali e ai ruoli dell’arte. Gran parte dell’arte moderna tende a distaccarsi dalla narrativa tradizionale e si avvicina all’astrazione.
La produzione artistica più avanguardista è spesso chiamata arte contemporanea o arte postmoderna. Guardando a ciò che scrivono diversi studiosi, ognuno offre una prospettiva diversa. Per esempio, il dott. Asim Bad al-Amir, scrittore iracheno, discute gli aspetti estetici e pittorici dell’arte moderna:
Se gli studiosi del pensiero estetico considerano la filosofia aristotelica come una pietra angolare—rivoluzionando il concetto stesso di bellezza—è perché Aristotele mantiene la bellezza entro il regno del mondo fisico, permettendo di misurarla e apprezzarla secondo proporzione e grandezza, a suo avviso. Questo rappresenta un cambiamento significativo nella struttura dei concetti estetici, i cui effetti perdurano ancora oggi.
In precedenza, il pensiero greco, in particolare Platone, aveva seguito un percorso governato dalla logica e dall’idealismo, rafforzato dalla sensibilità mistica e poetica, mirante a indicare un mondo al di là della nostra esperienza empirica. Questo mondo, sospeso e elevato, è al di là della capacità dei sensi, che non possono percepire oltre il regno empirico — un regno relativo e limitato.
Sebbene il pensiero aristotelico si sia esteso alla letteratura, alla poesia, al teatro e ad altri campi intellettuali, il suo impatto sulle arti visive è stato in gran parte trascurato. Ciò sottolinea l’importanza di riscoprire e apprezzare le idee pionieristiche di questo filosofo materialista e oggettivo. Aristotele ha facilitato l’interazione con i fenomeni estetici collocandoli nell’esperienza umana, senza fare affidamento sulla teoria platonica delle forme ideali.
Il pensiero idealistico ricevette un ampio consenso nelle arti visive del Rinascimento, al punto che Leonardo da Vinci stesso lavorò per incarnare i principi dell’idealismo, mostrando una tendenza duplice tra idealismo e sensualità. Basta osservare attentamente il suo celebre capolavoro, la Gioconda — che inaugurò una nuova era nel ritratto — per diverse ragioni:
* Essa trasferì la bellezza dall’ideale celeste a una caratteristica terrena.
* L’opera dimostra le prime applicazioni dell’ottica e della prospettiva e rivela la capacità della percezione sensoriale di trasmettere la bellezza ideale in modo coerente con gli obiettivi del pensiero rinascimentale, che cercava un equilibrio tra aspirazione spirituale e esplorazione della bellezza nascosta nel mondo materiale.
Sebbene questo approccio fosse relativo nella sua natura, rappresenta un punto cruciale di innovazione rispetto all’arte medievale, rigidamente idealistica.
Passando al Romanticismo, spesso considerato l’ultimo baluardo dell’idealismo nell’arte, esso agì come una forza contraria ai concetti razionali che dominavano il XVIII secolo, seguendo le proposte di Cartesio. Il Romanticismo riportò il cogito al “sento, quindi sono”, sostituendo la logica razionale con intense emozioni e passioni.
Il Romanticismo privilegiava l’ambiguità rispetto alla ragione, la libertà individuale rispetto ai vincoli dell’intelletto, l’emozione rispetto alla riserva, e l’ignoto rispetto al familiare. Tali alternative marcate resero questo movimento rivoluzionario un punto di svolta nella storia intellettuale europea sin dall’alba dell’epoca gotica, che aveva largamente trascurato le esperienze affettive.
In questo contesto, si può ancora discernere una tendenza aristotelica che non può essere ignorata. Aristotele sottolineava che i modelli estetici non richiedono necessariamente l’imitazione; l’elevazione o l’abbassamento di questi modelli, mediante aggiunta o alterazione, è sufficiente.
Allo stesso tempo, l’estetica kantiana, con il suo orizzonte immaginativo ed emotivo, ha riesaminato la natura dell’estetica come mera questione di giudizio piuttosto che di ragionamento logico. Kant sfidava l’autorità della ragione, suggerendo che l’esperienza sensoriale consente all’emozione di svolgere un ruolo centrale nella formulazione delle valutazioni estetiche necessarie.
Non c’è dubbio che le idee di Kant abbiano avuto un forte eco nel Romanticismo, che enfatizzava l’attività immaginativa libera, richiamando le conclusioni raggiunte dallo stesso Kant.
Secondo il pensiero romantico, l’immaginazione ha la capacità di generare immagini senza fare affidamento sui sensi. Di conseguenza, il Romanticismo sfidò i concetti classici che glorificavano standard come simmetria, proporzione e equilibrio. Invece, si basò sul principio ampio dell’immaginazione, trasformandola in un campo creativo illimitato, ricco di immagini, non più monopolizzato dal mondo materiale.
Vale la pena ricordare il consiglio di Delacroix, espresso in tono satirico in risposta al movimento realista: “Chiudete gli occhi quando dipingete.” Qui, il leader del Romanticismo nega la primazia dei sensi, incapaci di produrre immagini come fa l’immaginazione.
La pittura europea moderna, situata nell’interazione tra il bello e il sublime, o tra il sensibile e l’assoluto, ruotava necessariamente attorno a tale dualità, che divenne un asse centrale del pensiero estetico. Questo approccio influenzò il Cubismo durante il primo decennio e parte del secondo decennio del XX secolo.
Paul Cézanne, grande pioniere, si concentrò seriamente sul demolire gli standard convenzionali che avevano dominato la pittura europea sin dall’inizio del Rinascimento, specificamente dall’era di Giotto nel XIII secolo. Cercò di restituire alla superficie pittorica il valore di un testo portatore di conoscenza accurata di peso, massa e spazio, un approccio che influenzò ampiamente i movimenti della pittura moderna.
Le esplorazioni di Cézanne, in particolare quelle note come forme pure, riflettono un riferimento platonico. Tuttavia, da un’altra prospettiva, esse presentano anche una base aristotelica: i suoi studi preparatori per il Cubismo non trattavano la bellezza come legata al mondo materiale effimero, bensì cercavano l’essenza nascosta, dove le verità appaiono più complete e autentiche.
Le tendenze idealistiche e razionali di Cézanne sono evidenti: i modelli mentali che perseguiva nella sua arte richiamano le conclusioni di Aristotele. Creare bellezza non richiede necessariamente un rigoroso rispetto della realtà; spesso le verità si manifestano al di là delle apparenze immediate. Cézanne trasformò i dati della pittura impressionista, ampliando la distanza e la divergenza dalla realtà.
Ciò giustifica l’emergere del Formalismo nell’arte, che successivamente crebbe nella pittura astratta, enfatizzando la forma con intensità spirituale.
Come osserva Sarah Al-Tamimi: l’arte moderna è una reazione o risposta del mondo alle pratiche razionali e alle nuove prospettive derivanti dagli sviluppi tecnologici successivi all’era industriale. Essa ha permesso alla società di esprimersi in modi differenti dalle convenzioni tradizionali. Gli artisti, a loro volta, presentano e rappresentano le proprie esperienze della modernità, applicandole in modo innovativo nella vita e nella pratica artistica.