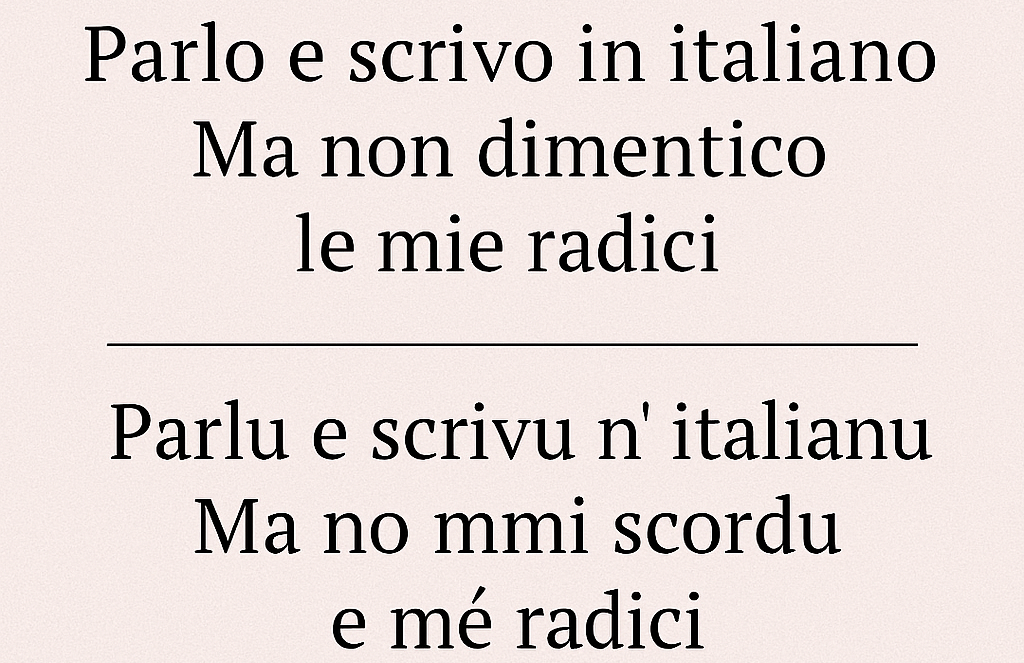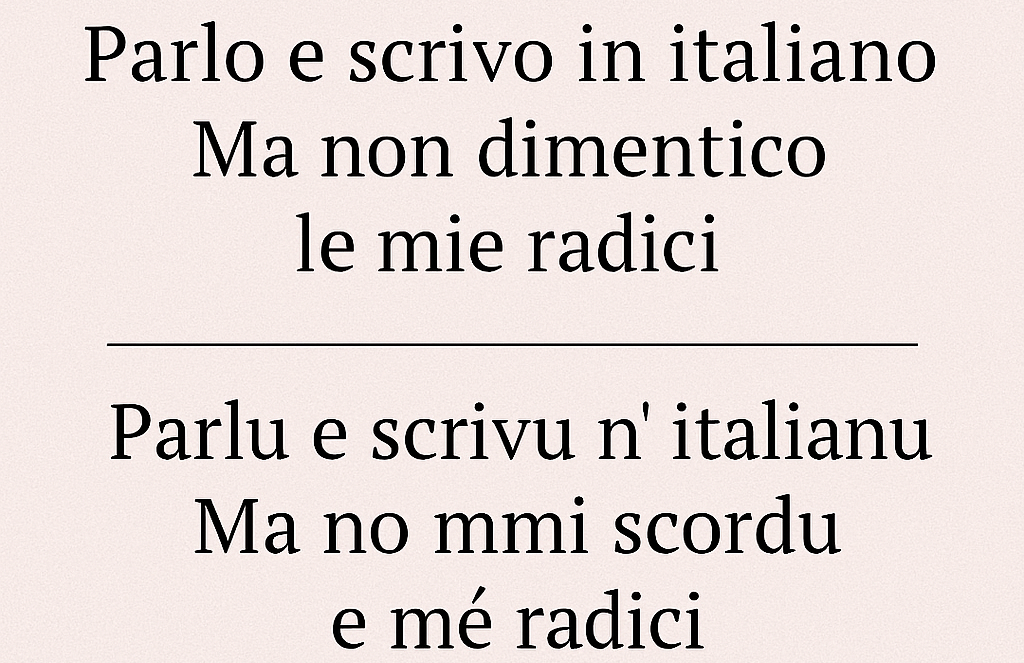SCRIVERE E PARLARE IN DIALETTO SIGNIFICA RICORDARE LE RADICI
OGNI PAROLA È UN PASSAGGIO
Il dialetto calabrese come memoria viva e ponte tra le culture
Di Francesca Gallello Gabriel Italo Nel Gòmez
Scrivere in dialetto è come parlare con gli antenati. Ogni parola porta il peso di un gesto, di un amore, di una paura. Ogni accento è un’impronta lasciata da chi è passato, ha amato, ha combattuto, ha cucinato, ha pianto. In Calabria, il dialetto non è solo lingua: è stratificazione, è resistenza, è poesia. Francesi, Greci, Saraceni, Spagnoli, Bizantini, tutti hanno lasciato un seme, una sillaba, un suono. E noi, oggi, li pronunciamo senza saperlo, come se la bocca fosse un archivio.
La Calabria è stata crocevia di popoli e civiltà. Ogni dialetto locale, da quello di Cirò Marina a quello di Bova, da Scilla a San Luca, racchiude parole che non appartengono a un solo ceppo, ma a molti. “Trupìa”, “scialare”, “mbruglià”, “jamu”: termini che portano tracce greche, arabe, latine, francesi. Alcuni dialetti conservano ancora la struttura del greco antico, come quello grecanico di Bova, dove si dice "enìo" per dire "vieni", e "chòra" per "paese".
La Calabria non ha un solo dialetto, ma una costellazione. Secondo gli studi linguistici, si contano almeno cinque macroaree dialettali, con decine di varianti locali:
Settentrionale (cosentino): con influenze campane e lucane.
Centro-settentrionale (catanzarese): più vicino al napoletano.
Centro-meridionale (reggino): con forti tracce grecaniche.
Meridionale estremo (area grecanica): dove sopravvive il greco di Calabria.
Arbëreshë: parlato nelle comunità albanesi, con contaminazioni italiane e greche.
Ogni paese ha il suo suono, il suo ritmo, la sua grammatica emotiva.
Il dialetto non è solo comunicazione: è intimità. È la lingua della nonna che sbuccia le melanzane, del padre che impreca, del bambino che chiama la madre. È la lingua del lutto e della festa, del corteggiamento e della vendemmia.
Scrivere poesie in dialetto significa salvare il non detto, dare voce a ciò che l’italiano standard non sa dire. Significa restituire dignità a una lingua che è stata spesso considerata “inferiore”, ma che è in realtà più ricca, più antica, più vera.
Oggi, il dialetto rischia di scomparire. Le scuole lo ignorano, i giovani lo abbandonano, i media lo snobbano. Ma il dialetto è memoria storica, resistenza culturale, identità fluida.
Tramandarlo significa non perdere il filo. Significa ricordare che siamo fatti di passaggi, di contaminazioni, di mescolanze. Che la nostra lingua è un mosaico, non un monolite.
Il dialetto non chiude ma apre. Accoglie parole straniere, le trasforma, le rende proprie. È un ponte tra generazioni, tra popoli, tra lingue, tra storie.
Ogni parola dialettale è una carezza che viene da lontano. E scriverla, oggi, è un atto d’amore.